
La "SATI"

- Fra tre giorni si compirà, sulle rive del Gange, un oni-gomon a cui devono prendere parte le bajadere e le nartachi della pagoda di Kalí ed il manti certo non vi mancherà.
- Che cos'è questo oni-gomon? - chiese Sandokan.
- Si brucerà la vedova di Rangi-Nin sul cadavere del marito, il quale era uno dei capi dei Thugs.
- Viva?
- Viva, sahib.
- E la polizia anglo-indiana lo permetterà?
- Nessuno andrà ad informarla.
- Credevo che quegli orribili sacrifici non si compissero piú.
- Il numero è ancora assai grande, non ostante la proibizione degli inglesi. Se ne bruciano ancora molte delle vedove, sulle rive del Gange. [E.Salgari "Le due Tigri", Donath 1904]
|
Salgari ci descrive così la "sati" cioè il suicidio rituale della moglie, rimasta vedova, che si immola sulla pira funebre del marito.
 In
sanscrito "sati" significa "moglie virtuosa". Il sillogismo quindi è evidente: la moglie che si sacrifica alla morte del marito è "virtuosa", onorabile, esemplare, la moglie che trasgredisce a questo imperativo sociale è una vergogna per se e per la propria famiglia, portatrice funesta di malasorte, destinata ad essere allontanata dalla casa, ripudiata dalla propria famiglia, in un mondo dove "famiglia", ricordiamolo, significa sostentamento, rispetto e
protezione.
In
sanscrito "sati" significa "moglie virtuosa". Il sillogismo quindi è evidente: la moglie che si sacrifica alla morte del marito è "virtuosa", onorabile, esemplare, la moglie che trasgredisce a questo imperativo sociale è una vergogna per se e per la propria famiglia, portatrice funesta di malasorte, destinata ad essere allontanata dalla casa, ripudiata dalla propria famiglia, in un mondo dove "famiglia", ricordiamolo, significa sostentamento, rispetto e
protezione.
L’usanza
della sati trovava la propria giustificazione religiosa nel mito di DAKSA.
Brahma aveva creato DAKSA,
il primo brahamano, a cui aveva delegato l’onere della pratica ortodossa del
sacrificio. Daksa era cioè il sacerdote perfetto che praticava i riti e i
sacrifici con perfezione e quindi grande fu il suo sconcerto quando una delle
figlie, Sati, dichiarò che voleva prendere come marito Shiva.
Questo
dio frequentava i cimiteri, era nemico dei riti e delle regole, girava con il
corpo cosparso di cenere, i capelli lunghi, con ossa e teschi a adornarlo.
Infine viveva d’elemosina che raccoglieva utilizzando una ciotola ricavata da
un teschio. Ma Sati fu irremovibile, sposò Shiva e andò ad abitare con lui sul
monte Kailasa, nell’Himalaya.
Un giorno Daksa officiò un
grande sacrificio in cui furono fatte offerte a tutti gli dei eccetto che a
Shiva. Sati, presente al rito, per la vergogna si gettò sul fuoco lasciandosi
bruciare viva. Mentre Sati bruciava Shiva, che era rimasto sul monte Kailasa,
si strappò una delle trecce e la gettò a terra. Non appena la treccia toccò il
suolo si generò un essere orribile di nome VIRABHADRA.
Questi raggiunse il luogo
del sacrificio di Daksa e distrusse ogni oggetto cerimoniale, frantumò mattone
per mattone l’altare del sacrificio, storpiò numerosi dei ed infine decapitò
Daksa e gettò la sua testa nel fuoco.
E’ in ricordo di questo
primo sacrificio di Sati, personificazione della moglie perfetta, virtuosa e
fedele, che le vedove si immolavano, o venivano convinte a farlo, sulla pira
del marito.

In
realtà il significato del mito è più complesso e profondo. Esso si riferisce a
due diversi modi di amministrare la religione induista: il Brahmanesimo e la
Bakti.
Il
primo ruota attorno alla figura sacerdotale del brahmano: il rito è
caratterizzato da complicate serie di gesti, officiato rigorosamente
nell’antica lingua sanscrita, secondo cerimoniali codificati.
In
questo modo il rito non era più solo un simbolo di un episodio o di un profondo
concetto religioso bensì assumeva un valore suo proprio, fine a se stesso, al
pari di una formula magica.
Visto
così l’induismo diveniva una religione settaria, lontana ed astratta ai più.
Per questo al brahmanesimo si contrappose la bakti che professava un rapporto
diretto fra il seguace e la divinità, senza mediatori, senza riti. Per questo
il demone creato da Shiva distrugge tutti gli oggetti del cerimoniale di Daksa.
Al
di là del mito quindi, che forniva solo lo spunto per legittimare l’usanza
della sati, le vere ragioni della nascita e dell’incredibile seguito che essa
ebbe ed ancora oggi sembra abbia, soprattutto nelle zone rurali, è da
ricercarsi nella cultura indù.
Qui
la donna è considerata alla stregua di un oggetto di proprietà prima del padre,
cui “costa” una faticosa dote matrimoniale, poi del marito. Essa accudisce alla
casa senza però essere pari ad una nostra “casalinga” ma piuttosto ad una serva
nel più autentico senso della parola: lavora da sola tutti i principali generi
alimentari quotidiani (yogurt, farina, zuccheri,…) con enorme impegno giornaliero,
mangia per ultima dopo il marito, i figli maschi e le figlie femmine,
rigorosamente e separatamente in cucina. Oltre a ciò fabbrica mattoni, o
raffina lo zucchero o lavora i campi, ecc. .
Il rito della sati fu
proibito per legge nel 1829 da William Bentinck, Governatore Generale della
Compagnia delle Indie. Naturalmente dopo tale data si sono registrati ancora
casi di sati e l’ultimo di cui si ha notizia è datato, anche se può sembrare
incredibile, 1987!
Nel villaggio di DEORALA,
nello stato dell’India nordoccidentale del Rajasthan, una vedova di appena 18
anni si è lasciata bruciare accanto al corpo del marito. Il luogo della
cremazione è ben presto divenuto meta di pellegrinaggio ed adorazione da parte
di devoti indù.
Ma molti dubbi sussistono
sulla volontarietà dell’atto e nonostante una assoluzione in primo grado per i
32 abitanti del villaggio accusati, senza mezzi termini, di omicidio, la
questione, dal punto di vista legale, è ancora lontana dal concludersi.
L’India
si è spaccata in due nel giudicare l’accaduto: per gli abitanti delle città è
inconcepibile pensare che una donna, nel XX secolo, si possa uccidere sulla
pira del marito di propria volontà, mentre nei villaggi del Rajasthan si reputa
la cosa non solo possibile, ma anzi, da indicare come esempio e rivendicare con
orgoglio.
E’ questo uno degli infiniti
esempi che si potrebbero portare per mostrare la grandissima distanza, che va
oltretutto sempre più accrescendosi, che esiste tra India rurale e India
urbana.
Ad esempio nell’India rurale
le donne di casta elevata non riescono a risposarsi e in molte zone sono
sottoposte alle stesse restrizioni e divieti in vigore nell’antichità.
 Fortunatamente oggi non ci si aspetta, di norma, che si sottoponga
al rito della sati. Però ci si aspetta che si rasi la testa, dorma per terra e
viva come un asceta, digiunando e pregando per il marito defunto.
Fortunatamente oggi non ci si aspetta, di norma, che si sottoponga
al rito della sati. Però ci si aspetta che si rasi la testa, dorma per terra e
viva come un asceta, digiunando e pregando per il marito defunto.
Molte vedove, specie in
alcune zone del Bengala e degli stati vicini, decidono di andarsene, altre
volte invece sono proprio scacciate di casa dalla famiglia del defunto marito.
Molte si rifugiano a VRINDAVAN città dell’Uttar Pradesh (India settentrionale)
bagnata dal fiume sacro Jumna. La città, dedicata al dio Krishna, è detta "la
città delle vedove".
Qui le quasi dieci mila
vedove, facilmente riconoscibili perché tutte con la testa rasata (è loro
vietato pettinarsi) e vestiti con sari di colore bianco, vivono d’elemosina e
di quel poco che sono pagate dagli ashram dopo ore de ore di preghiere in onore
di Krishna e, soprattutto, dei donatori di fondi agli ashram stessi.
Nel Medioevo, nello stato
del Rajasthan, patria della casta guerriera dei Rajput, l’aspetto religioso (o
presunto tale) della sati si intersecava con l’aspetto guerriero. Mentre il
marito mostrava il proprio coraggio combattendo impavidamente contro i
musulmani invasori, con altrettanto coraggio la moglie si immolava sulla pira
del marito morto in battaglia.
Il sacrificio da parte delle
moglie dei guerrieri Rajput è detto
JAUHAR; se il corpo del marito non veniva
ritrovato e recuperato le vedove si gettavano in un pozzo di fuoco. Lo scopo
pratico era impedire di essere catturate dagli invasori musulmani e di
concludere la propria esistenza rinchiuse in un harem.
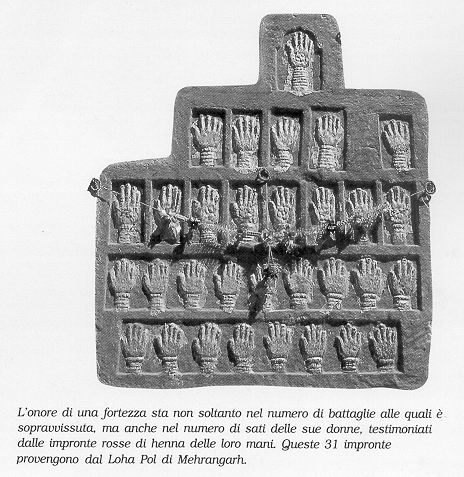
L’onore di una fortezza del
Rajasthan non è rappresentato soltanto dagli assedi a cui ha resistito ma anche
dal numero di sati/jauhar avvenute nel momento nelle sconfitte. Prima di
immolarsi le donne lasciavano l’impronta delle loro mani sulle mura della
fortezza, dopo averle immerse nell’hennè rosso. Pertanto maggiore è il numero
di impronte rosse sulle mura e maggiore è la gloria di una fortezza.
Ad
esempio, nel XIII secolo alla caduta della fortezza di Jaisalmer furono 24 mila
tra donne e bambini ad uccidersi piuttosto che subire l’infamia della
schiavitù.
Sempre a Jaisalmer accadde
che di fronte all’irrompere delle truppe nemiche non vi fosse il tempo di
mettere in atto il tradizionale jauhar ed allora il sovrano in persona decapitò
mogli e concubine; ma successivamente le sorti della battaglia mutarono e
l’assalto nemico respinto, rendendo vano il sacrificio delle donne reali.
Tornando
quindi a Salgari ed all’episodio citato in apertura, occorre sottolineare
ancora una volta come sfoggi un’ottima conoscenza dell’argomento che sceglie di
trattare. Addirittura egli usa non il termine sanscrito sati, ma "
oni-gomon",
di derivazione senz’altro più antica, probabilmente da una delle innumerevoli
lingue d’origine dravidiche. Cioè una delle lingue parlate dalle popolazioni
autoctone dell’India, precedentemente all’invasione degli Ari del secondo millennio
a.C.; alcune di queste lingue, ad esempio il tamil, sono parlate anche ai
giorni nostri nell’India del sud e vi si stampano libri e fumetti.


 In
sanscrito "sati" significa "moglie virtuosa". Il sillogismo quindi è evidente: la moglie che si sacrifica alla morte del marito è "virtuosa", onorabile, esemplare, la moglie che trasgredisce a questo imperativo sociale è una vergogna per se e per la propria famiglia, portatrice funesta di malasorte, destinata ad essere allontanata dalla casa, ripudiata dalla propria famiglia, in un mondo dove "famiglia", ricordiamolo, significa sostentamento, rispetto e
protezione.
In
sanscrito "sati" significa "moglie virtuosa". Il sillogismo quindi è evidente: la moglie che si sacrifica alla morte del marito è "virtuosa", onorabile, esemplare, la moglie che trasgredisce a questo imperativo sociale è una vergogna per se e per la propria famiglia, portatrice funesta di malasorte, destinata ad essere allontanata dalla casa, ripudiata dalla propria famiglia, in un mondo dove "famiglia", ricordiamolo, significa sostentamento, rispetto e
protezione.
 Fortunatamente oggi non ci si aspetta, di norma, che si sottoponga
al rito della sati. Però ci si aspetta che si rasi la testa, dorma per terra e
viva come un asceta, digiunando e pregando per il marito defunto.
Fortunatamente oggi non ci si aspetta, di norma, che si sottoponga
al rito della sati. Però ci si aspetta che si rasi la testa, dorma per terra e
viva come un asceta, digiunando e pregando per il marito defunto.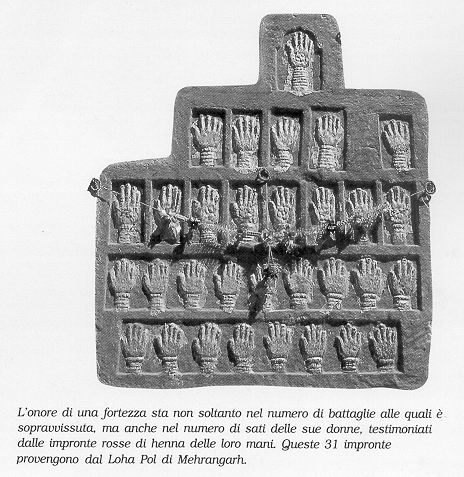 L’onore di una fortezza del
Rajasthan non è rappresentato soltanto dagli assedi a cui ha resistito ma anche
dal numero di sati/jauhar avvenute nel momento nelle sconfitte. Prima di
immolarsi le donne lasciavano l’impronta delle loro mani sulle mura della
fortezza, dopo averle immerse nell’hennè rosso. Pertanto maggiore è il numero
di impronte rosse sulle mura e maggiore è la gloria di una fortezza.
L’onore di una fortezza del
Rajasthan non è rappresentato soltanto dagli assedi a cui ha resistito ma anche
dal numero di sati/jauhar avvenute nel momento nelle sconfitte. Prima di
immolarsi le donne lasciavano l’impronta delle loro mani sulle mura della
fortezza, dopo averle immerse nell’hennè rosso. Pertanto maggiore è il numero
di impronte rosse sulle mura e maggiore è la gloria di una fortezza.